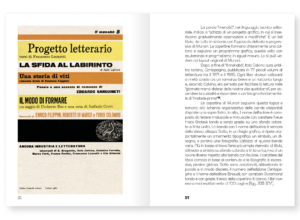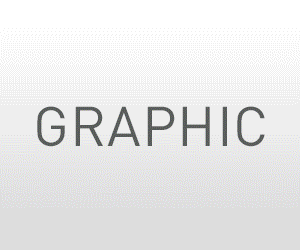Sta seduta sul terrazzo del suo appartamento, apparentemente rilassata mentre si versa un bicchiere di vino rosso. Non fosse per i seni, che nemmeno troppo furtivamente spuntano da sotto la giacca, non si capirebbe se nelle intenzioni di quell’irriverente di Juergen Teller ci fosse di ritrarre l’immagine di un uomo o di una donna. Né maschile né femminile, né questo né quello, come Roni. Uno, nessuno e centomila, verrebbe da dire ripensando al Moscarda di Pirandello, a quel suo nome brutto fino alla crudeltà, che per niente lo definiva, che nulla diceva del suo mondo interiore, “indiviso e pur vario”. Sulla natura indeterminata e contingente dell’essere androgino Roni Horn ha fondato la sua pratica, affermandosi come figura di rilievo della scena artistica contemporanea, con un vasto corpus di opere che spaziano tra linguaggi diversi: disegno, fotografia, scultura e libri d’artista. Il concetto di identità, o meglio, l’idea di un’enciclopedia di identità, è la chiave di ingresso al suo lavoro. Un filo conduttore che attraversa tutta la sua produzione, mettendo in questione le nozioni di genere e provando a riformularle in maniera né programmatica né deterministica. Non è un caso che Horn individui nel gruppo scultoreo Asphere (1986-2001) il suo autoritratto: sfere in acciaio inossidabile o rame, a prima vista familiari, ma che a uno sguardo più attento rivelano una irregolare rotondità, quasi impercettibile. Qualcosa di diverso da quello che ci si aspetterebbe. Un senso di straniamento che induce l’osservatore a guardare di nuovo, a guardare “tra”, per rivalutare ciò che si offre alla vista e ricodificarlo.

Nata a New York nel 1955, consegue il Master of Fine Arts in scultura presso la Yale University nel 1978. Gli anni della sua formazione coincidono con l’attività del movimento femminista e il crescente interesse per le politiche identitarie, ma sarebbe riduttivo inquadrare la sua ricerca nel perimetro di quelle ideologie. Quando è ancora una studentessa, e frequenta la Rhode Island School of Design, si cimenta in una performance intitolata Ant Farm (1974-75). In silenzio, difronte a un formicaio incastonato tra due lastre di vetro, tenute insieme da una cornice di legno, osserva la comunità operosa di insetti che come gli esseri umani rinegoziano lo spazio in funzione dei loro bisogni sociali. Sin dagli esordi l’indagine verte su cosa significhi identificasi o essere identificati, attraverso opere non strettamente associate alla retorica di maschile e femminile, ma che da entrambe attingono.

A partire dagli anni Settanta, il disegno si conferma attività centrale e costante, “primaria” come la definisce l’artista. Una tecnica che si evolve nel tempo, raffigurando forme astratte, secondo un processo di costruzione, decostruzione e ricostruzione che comprende anche segni, per lo più sotto forma di parole. Può essere il gergo della serie di acquerelli su carta Frick and Fracks, o le espressioni idiomatiche scritte a mano da centinaia di persone e selezionate dall’artista in Wits’ End Mash o ancora l’amalgama di citazioni, fotografie, appunti su notizie giornalistiche e testi scritti di proprio pugno, confluiti nella grande installazione LOG composta da 406 opere realizzate quotidianamente nell’arco di 14 mesi, tra il 2019 e 2020. Una mostra tutta incentrata sui disegni di Horn è ospitata sino al 19 settembre alla galleria Raffaella Cortese di Milano, che celebra così il suo trentesimo anno di attività.

Ripetizione, sdoppiamento, strutture geometriche, rendono facile associare le sculture di Horn all’estetica del minimalismo, ma è evidente che si tratta di una proposta più complessa, che non si esaurisce nella fascinazione per le forme pure e autonome. Gli oggetti apparentemente identici e disposti in coppie (Pair Objects) non sono realizzati con tecniche e procedimenti industriali. Non è la precisione nell’esecuzione e nemmeno la massima indifferenziazione a costituire l’essenza del lavoro; è piuttosto la relazione che si instaura, l’instabilità del rapporto che articolano tra loro. E allora viene spontaneo chiedersi cosa siano, se siano uguali o diversi e cosa significhi questa differenza. È forse l’integrazione delle differenze la fonte primaria dell’identità? Parrebbe di si, parrebbe svilupparsi proprio in quello spazio di separazione, liminale e di transito, dove l’io non si riconosce perché incapace di definirsi in maniera precisa e puntuale.

In una delle sue opere più palesemente autoreferenziali, Roni Horn aka Roni Horn (2008-2009), l’artista presenta una sequenza di autoritratti a coppie – istantanee tratte dall’album di famiglia – che la cristallizzano in varie fasi della sua vita, a partire dall’infanzia. Abbinate in modo da esaltare i fisiologici cambiamenti avvenuti nel tempo, tanto da rendere quasi irriconoscibile la stessa persona, le immagini sembrano sfidare le regole della percezione disattendendo l’aspettativa che la fotografia agisca come dispositivo rappresentativo e mimetico. È invece un luogo di mutevolezza e possibilità, che di certo non ha come preoccupazione principale la definizione del genere.

Da qualche parte nel mezzo, nel regno del fluido e del cangiante, è l’acqua a infiltrarsi, con le sue correnti vorticose, le sue profondità torbide, la superficie increspata dal vento. Uno specchio che funziona al contrario, rendendo vano ogni tentativo di fissaggio dell’identità. Ciò che nelle dimensioni del Tamigi è solo un piccolo dettaglio, diventa nell’installazione fotografica Still Water (The River Thames, for Example) (1999) una superficie avvolgente che consuma lo spazio visivo dell’immagine. Le note a piè di pagina riportano le riflessioni di Horn sulla natura dell’acqua, e del fiume in particolare, trasformando l’incontro visuale in un’esperienza di lenta e attenta contemplazione indotta dalla lettura dei testi. “State prestando attenzione ai numeri?”scrive l’artista. “Forse non leggerete tutte queste note a piè di pagina. Probabilmente vi stancherete e ve ne andrete. Ma ce ne sono altre: altre immagini, altre note a piè di pagina, dietro di voi o in fondo al corridoio o in un’altra stanza”.

Il senso di dispersione del sé che l’acqua suggerisce scorre sino al Circolo Polare Artico e trova nell’Islanda il suo territorio naturale e d’elezione. Un posto abbastanza grande per perdersi, abbastanza piccolo per trovare sé stessa. Lì Horn si colloca, definendosi una “turista permanente” e definendo ancora una volta la sua identità come uno stato intermedio. Ritratta a distanza ravvicinata si vede una giovane donna islandese, immersa fino al collo o alle spalle in una delle numerose sorgenti termali all’aperto. Le cento fotografie che ritraggono Margaret, e che compongono la foto-installazione You are the Weather (1995-1996), catturano le sue mutevoli espressioni facciali creando un orizzonte dinamico che non si stabilizza mai in un quadro fisso. Del resto, il fine ultimo dell’opera non è certo l’oggetto, che è solo un veicolo per la percezione, ma l’esperienza che lo spettatore fa in relazione all’oggetto e che lo trascina più profondamente nel mondo. Come? Invitandolo a costruirsi. Credete che si costruiscano soltanto case? “Io mi costruisco di continuo e vi costruisco, e voi fate altrettanto” ci ricorda Moscarda. E che belle costruzioni vengono fuori!

Location: Galleria Raffaella Cortese
Roni Horn 16 maggio – 19 settembre 2025
Milano, via stradella 7-1-4
Photography: Nils Rossi
Styling: Alex Vaccani
Fashion: YSL vintage