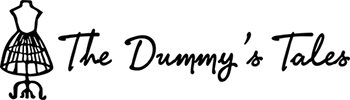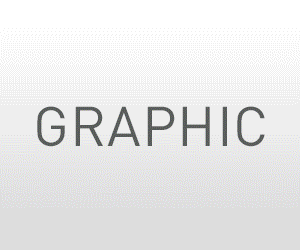Galleria Raffaella Cortese ha appena inaugurato la seconda personale, dopo quella del 2015, di Francesco Arena dal titolo “Tre sequenze per voce sola”. Un viaggio suggestivo che riconduce all’intensità e alla densità della poetica di questo artista – fatta di calcolo, numerazione, forme geometriche ma anche di aspetti etici che hanno a che fare con la sua propensione a indagare i fatti della storia – e che si snoda lungo la direttrice dei tre spazi della galleria.
Francesca Interlenghi: Come per la precedente tua personale hai deciso di realizzare anche in questa occasione tre lavori differenti destinati, ognuno singolarmente, ai tre diversi spazi della galleria. Mi racconti come è nata questa mostra, la sua genesi?
Francesco Arena: La mostra ha in realtà una genesi lunga. Era in programma un anno fa ma poi l’ho rimandata e i lavori sono cambiati completamente nel corso di questo anno. Direi che è fondamentalmente una mostra sul tempo, sulle diverse tipologie di tempo e sul modo in cui noi lo percepiamo. Ho incontrato questa frase di Virginia Woolf in ‘Gita al Faro’ che recita: “Anche la pietra che calci con lo stivale durerà più di Shakespeare”. Parole che hanno stimolato una riflessione sul fatto che il nostro tempo è sempre un tempo limitato, può essere più o meno lungo, ma è un tempo insignificante se confrontato con quello di altre cose con cui ci relazioniamo quotidianamente. La pietra, per esempio, sta lì da milioni di anni e continuerà ad esserci per altri milioni di anni probabilmente, indistruttibile quasi. Le opere indagano questo: il nostro concetto di tempo, di storia, di vita e il rapporto di tutti i giorni che noi abbiamo con oggetti che hanno una durata molto più estesa nel tempo della nostra.
Francesca: Com’è avvenuta l’interazione con lo spazio? E che tipo di relazione hai messo in atto tra opera e spazio?
Francesco: Tre opere diverse perché in realtà si tratta di tre racconti diversi che possono essere letti in maniera autonoma, distaccati l’uno dall’altro, ma che non si rapportano con lo spazio in maniera site specific. La scultura a forma di enorme triangolo cavo sospeso da terra dal titolo Angolo Scontento (Hommage à la mort de Sigmund Freud) non poteva che essere collocata in Via Stradella 7 e non poteva che essere incastrata in quella posizione, l’unica che le consentisse di stare sospesa garantendo allo spettatore la possibilità di girarle intorno. In Via Stradella 1 il grande masso di marmo che costituisce l’opera Marmo con 3274 giorni è stato scelto di un colore che ricorda il marmo verde del pavimento. E in Via Stradella 4 infine, il lavoro sonoro dal titolo Linea finita (orizzonte Gianluigi) è come fosse esso stesso diviso in due parti: la registrazione su nastro magnetico e la panca destinata a chi ascolta (ndr l’opera consiste in una bobina di nastro magnetico per registrazioni audio lunga quanto la distanza tra l’osservatore – Gianluigi – e il suo orizzonte, su cui è registrata la sua storia). Sono lavori che in qualche modo dialogano con lo spazio ma non sono dedicati in maniera specifica allo spazio, anche perché sono tutte opere destinate a muoversi e collocabili anche in altri contesti
Francesca: Il tema del movimento ritorna sempre nella tua arte. Lo stesso tuo concetto scultoreo ha a che fare con il movimento. Dentro strutture dalle forme geometriche, essenziali e scarne, l’umano e l’accadimento si muovono. L’opera Angolo Scontento (Hommage à la mort de Sigmund Freud) ospita una persona seduta, nata nel 1939, stesso anno della morte di Sigmund Freud, che racconta di sé e della sua vita. Oltre l’azione performativa, dentro la scultura c’è proprio la concretizzazione di questa linea temporale che va dalla morte di Freud ad oggi. Ed essa stessa, la linea intendo, non è statica bensì dinamica perché passando i giorni l’oggi diventa inevitabilmente ieri dilatando così sempre di più la distanza tra punto iniziale e finale della linea.
Francesco: Si è vero. E poi a un certo momento quest’opera non potrà più essere abitata, sarà destinata a rimanere vuota perché tra vent’anni sarà probabilmente difficile trovare qualcuno nato nel 1939 che possa stare seduto all’interno della scultura. Questo lavoro in realtà nasce da un altro che si intitolava Angolo stanco e che voleva essere un omaggio alla morte di Walter Benjamin. Lui, come Freud, sembrano figure così lontane e a me interessava fare un tentativo per avvicinarmi a loro; ragion per cui ho provato a percepire questa lontananza attraverso qualcosa di vivo, attraverso una persona viva. Tra noi e Freud c’è dunque la vita di questa signora di ottant’anni che è nata nello stesso anno della morte del padre fondatore della psicanalisi. Una lontananza colmata da una presenza, un vuoto riempito da un pieno.
Francesca: Questa questione del movimento che in modi diversi attraversa tutta la tua poetica mi è sempre parsa un tentativo atto a contrastare la finitudine dell’esistenza umana. Nella continua dialettica vivo/morto, finito/infinito leggo sempre uno sforzo fisico quasi, concreto e molto tangibile, per arginare il senso della nostra limitatezza.
Francesco: Si, e lo stesso si potrebbe dire anche in riferimento a tutti i miei lavori sulle misurazioni. Mentre gli oggetti, anche le sculture ovviamente, hanno la capacità di occupare lo spazio in maniera permanente, noi uomini siamo, come dire, dei pesi e delle misure che lo spazio occupano temporaneamente. Il fatto stesso che l’uomo abbia iniziato a un certo punto a seppellire i morti è un concetto estremamente interessante perché evidenzia la scomparsa fisica di una persona. L’idea che vivo è sopra e morto è sotto è, se vogliamo, un concetto semplice ma di fondamentale importanza per la nostra cultura. Ed anche questo, dal punto di vista oggettuale, è per me un aspetto affascinante: l’idea dell’arte che passa di mano. Un’opera trova sempre un prosieguo nel tempo e in qualche modo continua le storie di coloro che con l’opera si sono relazionati. E’ come se la finitudine del tempo si rapportasse con un altro tempo.
Francesca: Questo approccio molto primitivo alle forme scultoree ti deriva in qualche modo dall’asciuttezza del paesaggio della Puglia, terra dalla quale provieni? In che modo pensi ti abbia influenzato?
Francesco: Io sono brindisino, il mio è un paesaggio estremamente piatto costituito per lo più di terra battuta. Io dico che il mio è un paesaggio scultoreo perché fatto di profondità, larghezza e altezza. Proprio questo paesaggio così aperto, nel quale solitamente ci sono gli alberi e in mezzo piccole case fatte a forma di cubo, di una sola stanza, ha indubbiamente contribuito a formare quello che è il mio immaginario estetico.
Francesca: Anche la scelta e l’utilizzo dei materiali è di fondamentale importanza per te. Il marmo, il rame, la pietra – solo per citarne alcuni – hanno valenza tanto sul piano formale quanto su quello semantico. Dico bene?
Francesco: Cerco sempre di utilizzare i materiali nella loro essenzialità. In ogni mia opera c’è uno sforzo minimo nel senso che l’opera è composta dal lavoro necessario per farla. Niente di più. Così solitamente la scelta di un materiale è strettamente legata al tipo di lavoro che voglio conseguire. Per esempio per me non ha senso che un’opera che nasce in bronzo venga poi realizzata anche con un altro materiale. L’opera si compone sempre di due elementi differenti: il materiale e l’informazione concettuale su cui la mente di ognuno di noi lavora per arrivare alla concretizzazione dell’opera stessa. Il materiale ha una sua intrinseca caratteristica fisica – può essere morbido, duro o resistente – però ha anche un suo valore etico. Incidere una frase su una lavagna con un gessetto ha un senso. Inciderla su una lastra di bronzo o marmo ha un senso differente. Sono due cose diverse. La scelta del materiale è allora funzione di cosa deve essere l’opera, di quanto deve durare, di quali informazioni deve contenere e di come queste informazioni possono trasparire in qualche modo dalla materia. Perciò, una volta chiariti questi punti, il lavoro che deve essere fatto non deve essere lezioso, deve essere quello che serve. Il sovrappiù non mi interessa.
Francesca: Infatti, non è l’estetica della ridondanza la tua ma nemmeno quella della rarefazione direi. Pur parlando di ricordo e memoria, sia collettiva che individuale, la tua trasposizione in opera è sempre una risultante molto solida, concreta, che mai cede il passo a quel senso di evanescenza – rarefazione appunto – che il ricordo potrebbe in qualche modo evocare.
Francesco: E’ proprio una solidificazione la mia tant’è che io dico spesso che le storie sono affogate nell’opera. Un esempio in tal senso è il lavoro che muove dalla vicenda di Stefano Cucchi, Marmo con 3274 giorni (ndr blocco di marmo scavato in modo da ospitare un numero di fogli di agende corrispondenti ai giorni che vanno dal 23/10/09, data della divulgazione mediatica del decesso di Stefano Cucchi, al 10/10/2018, data della testimonianza che incrimina i carabinieri responsabili della sua morte). L’opera è il nocciolo, l’elemento essenziale che deve contenere tutte le informazioni, anche quelle nascoste. La storia infatti è spesso celata all’interno dell’opera e deve essere raccontata in qualche modo.
Francesca: L’opera come necessità ma poi a un certo punto l’opera bisogna lasciarla andare, abbandonarla al suo destino, che è il destino degli altri.
Francesco: L’opera è una necessità nel senso che serve a me per sviluppare un pensiero. Così la scultura: è una necessità mia che poi io condivido naturalmente con gli altri perché mi fa piacere. A quel punto però l’opera è suscettibile di interpretazioni e significati diversi rispetto a quelli che io le avevo attribuito. Ma è giusto che sia così, anzi a volte proprio gli altri hanno dato interpretazioni del mio lavoro che ho trovato molto più interessanti delle mie. Non provo particolare affezione per le mie opere e non sono mai dispiaciuto quando una se ne va. Sono dell’idea che gli artisti non si godano mai il momento. Oggi presento un lavoro ma quel lavorio in realtà per me si era concluso tempo indietro e il pensiero nel frattempo si è già spostato su qualcos’altro. Rimane comunque bello rivedere i propri lavori a distanza di anni e rileggerli in maniera diversa.
Francesca: In questa dialettica che metti in atto tra storia personale e la Storia, tra memoria individuale e memoria collettiva, tu come artista a che distanza ti poni? Dove sei collocato?
Francesco: La distanza è legata alla questione dell’informazione e del recepire un’informazione. Ma quotidianamente sono così tante quelle che ci arrivano che sceglierne una, qualcosa su cui ragionare, è sempre molto difficile. Alla fine la scelta di un tema con il quale rapportarsi e con il quale cercare vicinanze e distanze, cercando altresì una linea che le unisca, avviene sempre per stratificazione. Perché le cose si stratificano e a un certo punto la maggior parte di esse vengono dimenticate e quello che rimane è giusto l’essenziale. Penso ai lavori su Moro o Pinelli o sui profughi siriani: le loro vicende sono rappresentative di qualcos’altro, non solo delle loro esperienze individuali, ma di concetti più ampi che riguardano tantissime altre persone. E’ questo che crea vicinanze e distanze per me.
Francesca: In tutto questo calcolare e misurare e ponderare rimane alla fine il dato imponderabile della distanza variabile dalla quale lo spettatore decide di osservare il tuo lavoro e con esso instaurare il proprio dialogo. In questo scambio reciproco tra opera e fruitore dell’opera, tu come artista quale ruolo ritieni di avere?
Francesco: L’artista cerca di trasmettere quella che è una propria visione che naturalmente non è mai frontale sulle cose, è sempre laterale ed è sempre anche una visione opaca, non chiara. Forse le visioni chiare le possono dare gli storici ma l’artista io credo di no, l’artista non mostra quello che è reale. Può mostrare qualcosa che è realmente accaduto o accade ma lo restituisce sempre con un certo livello di astrazione. Secondo me il punto di vista dell’artista è sempre un po’ confusionario, almeno, io preferisco sempre la confusione, perché semplicemente l’opera non deve essere dogmatica. Piuttosto deve suggerire delle domande, indurre lo spettatore a porsi degli interrogativi. Primo tra tutti: qual è la necessità che spinge le persone a lasciare una traccia? Certo, lasciare un segno di sé ma forse, più di tutto, il desiderio di comunicare qualcosa che non è completamente spiegabile. Allora io cerco di spiegarlo attraverso le forme.
Francesca: Le forme si. Dentro le tue, che a ben vedere si estendono oltre il chiuso del loro perimetro, ci ho sempre visto la vita e tutti gli elementi che sono significato e significanti della vita. Tutta la lotta. E la tensione. Dell’Uomo.
Desidero ringraziare per la cortese intervista Francesco Arena.
Francesco Arena, Tre sequenze per voce sola
Galleria Raffaella Cortese, via A. Stradella 7-1-4 – web site – Facebook – Instagram
14 marzo – 24 aprile 2019 | martedì – sabato h. 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:30 e su appuntamento
Foto di Elisabetta Brian