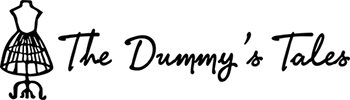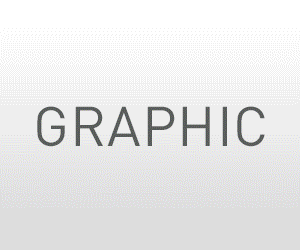53 anni, di cui 29 spesi all’Istituto dei Tumori di Milano. Una laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano e due Diplomi di Specialità: uno in Ematologia e un altro in Pediatria. Dal 1989 Dirigente medico a tempo pieno presso la Divisione di Oncologia Pediatrica a cui si aggiunge, da luglio 2010, anche la carica di Primario. Ma dopo e oltre l’elenco dei titoli di una donna sempre bravissima a scuola che i genitori avrebbero voluto studentessa di Economia e Commercio o Matematica perché “erano veramente troppi gli studenti di medicina rispetto alle attese professionali e nella testa delle persone consapevoli c’era l’idea che si finisse a fare i disoccupati, o i mal occupati, o i sotto occupati”, dicevo, dopo e oltre questo mero elenco di titoli c’è tutta la storia e il senso di una vita vissuta al servizio degli altri. Come fosse un modo efficace di cogliere le sfide dell’esistere. Occuparsi delle cose impossibili e rendere così costruttiva la rabbia per certe provocazioni, certa insensatezza, della vita.
“Non saprei dire quando ho scelto medicina, mi sembra in realtà di non aver mai scelto niente di diverso. Forse, più che altro, ho solo deciso di oppormi a quelli che non volevano che facessi medicina. Ho cominciato a pensare di occuparmi di tumori dei bambini che ero al secondo anno di università. Ero molto giovane ed era molto presto. E ho un ricordo preciso. Avevo 19 anni e ero andata con un gruppo di ragazzini disabili in vacanza. Al passo del Tonale, in un paesino nelle vicinanze di Pejo, ho trovato una piccola libreria proprio all’ingresso di una chiesa. Un libro dal titolo “Bambini come gli altri” aveva catturato la mia attenzione. Scritto da un pediatra oncologo americano raccontava la storia di bambini con tumore e mi era parso un libro così assurdo in un posto del genere. Me lo sono sempre ricordato quell’episodio.”
Ci sono i bambini ammalati all’Istituto dei Tumori. Ci sono i bambini. E poi c’è anche la loro malattia. Ma non è che un bambino malato sia diverso da un altro bambino. Rimane un bambino. E quando una persona si occupa di bambini e di ragazzi deve aver bene in mente che i bambini e i ragazzi sono uguali sia da sani che da malati. Che hanno gli stessi pensieri, le stesse reazioni, la stessa voglia di giocare, le stesse paure. Questo è un posto in cui non c’è talento che non debba non essere impiegato, un posto in cui tutte le competenze che si maturano come essere umani tornano buone, in cui le tappe della vita umana aiutano quelle della vita professionale e viceversa.
“Ero una bambina anche io, avevo solo 14 anni quando ho perso un cugino di appena 16 per un osteosarcoma. Io allora non avevo assolutamente capito niente di niente, avevo solo capito che prima lui c’era e poi non c’era più. Ma nel giro di pochissimo tempo. Parlo di quasi 40 anni fa, eravamo proprio agli albori della terapia adiuvante e si faceva una stranissima chemioterapia. Quindi in realtà il primo ragazzo amputato che ho visto nella mia vita è stato questo cugino. Il primo paziente è stato lui, la prima persona reale. Ho vissuto quella storia senza capire assolutamente nulla. Io ascoltavo quello che dicevano i grandi ma penso che anche loro non capissero fino in fondo o forse non riuscivo io a darmi pace di un evento così terribile.”
Ho avuto anche io, netta, la sensazione di non capire un granché mentre guardavo gli adulti entrare e uscire dal reparto. Gli adulti. Più che i bambini. Gli adulti e il loro scambio di comunicazioni. Quelli che dicono delle cose disposti ad accogliere quello che viene dopo. Quelli a cui tocca fare gli aguzzini. E quelli a cui tocca consolare. Figure plurime che si muovono dentro gli stessi identici interrogativi.
“Rimane, oggi come il primo giorno, una sensazione di assoluta inadeguatezza. Di inadeguatezza e incompetenza che non ho mai superato a dire il vero e mi trascino ancora dietro. Mi ricordo che quando sono arrivata non sapevo nulla, avevo paura perfino di fare del male ai bambini, non sapevo se si poteva essere affettuosi o no con loro. Cioè, se si potevano accarezzare e toccare. Non sapevo visitare praticamente nessuno, men che meno i bambini. Oggi, dopo 29 anni, di certo non sono più così impacciata ma mi sento ancora, come allora, insufficiente.”
Poi una grande fatica, perchè si deve fare innegabilmente una grande fatica a tenere tutte le cose insieme. La pressione politica del ruolo, il dolore compagno di ogni singolo giorno, le questioni della propria famiglia, un marito medico anche lui, due figli che crescono, il passaggio dall’essere una tra gli altri all’essere primario, quindi primus inter pares, tutt’altro che semplice da gestire.
“Io sono l’unico primario donna di un reparto clinico qui dentro. E non mi sono accorta di essere una donna fino a tempi recenti, rispetto ad alcune cose che mi sono accadute. Quelle cose non sarebbero successe ad un uomo. Non è l’impossibilità di fare carriera o di ottenere dei riconoscimenti scientifici o dimostrazioni di stima e affetto da parte dei pazienti e delle famiglie. E’ un certo tipo di disturbo della mia attività che non si sarebbe mai verificato se io fossi stata un uomo E di questo ne ho la certezza. Non è stata una bella cosa tanto più che vivevo nell’illusione che le questioni relative alla differenza di genere fossero delle cose un po’ da vetero femminismo. Invece, purtroppo sulla mia pelle, mi sono accorta che il vetero femminismo non ha ancora prodotto i risultati sperati.”
Questa donna da cui si dovrebbe solo imparare, capace di trattare con la stessa competenza tanto gli aspetti della cura quanto quelli di un’azienda sempre in affanno che riflette tutta la debolezza di un modello di welfare non più sostenibile, questa donna piena di tanto eppure incapace di essere piena di sé, dice che alla fine è stata lei a imparare, quasi vantasse un debito anziché un credito nei confronti del suo percorso di vita.
“Tra i talenti che ho acquisito negli anni sicuramente la pazienza, che non avevo, la capacità di stare zitta e di ascoltare, il non arrabbiarsi. La tolleranza nel senso buono del termine, la tolleranza della differenza, la tolleranza della disperazione. Perché non guarire qui dentro significa morire. E allora bisogna saperla tollerare la disperazione e accoglierla, anche quando tira fuori il peggio dagli esseri umani.”
Desidero ringraziare la Dottoressa Maura Massimino per avermi regalato il tempo di questa conversazione. Che mi è sembrata il modo più degno per chiudere questo 2015.
Le foto sono del Dottor Andrea Ferrari, che ringrazio.