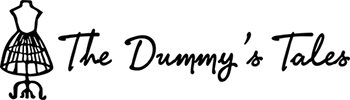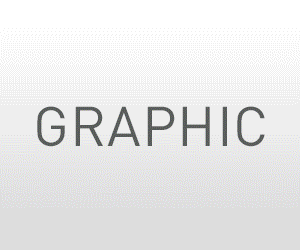Luce. Nelle distillate atmosfere del bianco e del nero, nel malincuore di un edificio industriale, uno stato d’animo, una emozione. E insieme le architetture urbane e l’infinito, la natura morta e l’oblio. Un territorio visivo che è una landa sterminata in cui figure e oggetti si muovono come sopravvissuti a un sapere della morte.
Direi che la fotografia ha avuto per me una sorta di valenza salvifica perché è diventata un mezzo di espressione, probabilmente il mezzo privilegiato.
“Io riesco a raccontare qualcosa di me con le mie fotografie, ma prima ancora che raccontarlo agli altri lo racconto a me stesso. Non è facile guardarsi dentro e a volte non è nemmeno facile farsi guardare. Però possiamo specchiarci in quello che facciamo, osservarci e fare un percorso a ritroso. Quando io scatto e guardo l’immagine che ho prodotto io vedo qualcosa di me riflesso lì dentro.”
L’incontro con la fotografia avviene che Matteo Guariso ha 16 anni, per caso, durante una gita sul Lago di Garda quando si fa prestare la macchina fotografica da un amico. Ed è subito passione. Segue la specializzazione in Fotografia di Moda allo IED di Milano e la collaborazione professionale con diverse agenzie. Una carriera che gli permette di misurarsi con la ritrattistica, il reportage, l’architettura, lo still life spaziando dentro un perimetro dai contorni fluidi.
“Quella volta, al Lago, mi è capitato di fare un ritratto a una persona, uno foto rubata. Stampando la diapositiva, era ancora il periodo dell’analogico, sono rimasto colpito non tanto dall’immagine in sé quanto dalla potenzialità di espressione che il mezzo aveva. Tant’è che poi mi sono attivato per ritrovare quella persona che pur non conoscendo avevo fotografato lasciandogli una stampa di quello scatto come segno di gratitudine per quella occasione che mi aveva fatto scoprire la fotografia.”
Lungo il cammino la fascinazione di maestri importanti. Helmut Newton per la sua capacità di narrazione attraverso le immagini, raffinatissima e ironica, e per la sua abilità innovativa. Quel voyerismo quasi sublimato, una sorta di osservazione partecipata. E Robert Mapplethorpe, una folgorazione assoluta, per la pulizia e l’estrema disciplina che risalta dalle sue immagini. Per essere riuscito a raccontare una storia che gli apparteneva, una storia forte come quella della sua omosessualità, veicolando un messaggio controverso in maniera artistica, utilizzando il turbamento suscitato dalle immagini pornografiche come motore emotivo per dare impulso progettuale alle sue fotografie.
Un processo creativo, quello di Matteo, che di folgorazioni si alimenta, che nasce sempre da un colpo di fulmine per qualcosa che si frappone tra lui e il reale in forma di immagine immediata e subitanea. Segue un lavoro di concretizzazione, una pre-produzione che è fondamentale per capire come fare a dare vita a quella intuizione, come rendere vive le immagini che arrivano, che accadono quasi, armonizzando l’esteriore con l’interiore e il poetico.
Fotografo solo quello che mi va di fotografare, o meglio, sarebbe più corretto dire che fotografo quello a cui io piaccio. Sono le cose che mi scelgono, non viceversa, non sono io che vado in cerca.
“Al punto che molto spesso mi capita di comprendere solo dopo mesi il perché di una determinata fotografia. Anzi di alcune non ho ancora capito esattamente il perché ma so che dovevo fare proprio quello scatto e proprio in quel momento. Più una esigenza che un vezzo, qualcosa di cui non posso fare a meno, forse una forma di dipendenza. Può essere letto in tanti modi. E non importa che a scegliermi sia un paesaggio, il volto di una persona, una natura morta. Non mi interessa. Se avere una cifra autoriale significa fotografare sempre le stesse cose, che io debba fotografare sempre fiori perché ho iniziato fotografando fiori, io dico che non mi interessa.”
Ma la sua fotografia è anche uno spazio comune che aspira ad accorciare le distanze tra due interlocutori, il fotografo e il fotografato, per tentarne una relazione. Luogo in cui l’estraneità reciproca tende a un rapporto di unità pur nel rispetto delle pluralità. Uno spiraglio segreto al di fuori delle cose e delle persone in cui si riassumono i modi di vedere e di sentire. Una lettura continua di territori paralleli.
“Il ritrarre una persona comporta un coinvolgimento molto profondo. Quando il soggetto da ritrarre si pone davanti all’obiettivo con la consapevolezza di quello che sta accadendo è come se lasciasse le chiavi di casa sua a qualcuno che è libero di entrare e guardare quello che c’è dentro. Diventa un gioco di specchi. Tu mi permetti di raccontarti per come ti vedo, che non è una cosa banale, e io stesso mi vedrò in quel racconto riflesso. Tu vedi te stesso attraverso i miei occhi ma io vedo anche me stesso riflesso in quella foto per quello che ho voluto raccontare e per come l’ho raccontato. Ecco perché quando ritraggo una persona io la voglio sempre incontrare prima, voglio cercare di capire chi è, quale è la sua storia, cosa vuole dire di sé con una fotografia. Una cosa assolutamente antitetica rispetto a una serie di dinamiche di tipo commerciale che però non devono mai andare a sottrarre la valenza mistica di una situazione di questo genere, un contatto tra due mondi che generano delle alchimie.”
Una luce di derivazione pittorica, perché la fotografia è luce di fatto. L’esempio arriva dai maestri fiamminghi e dallo studio dei loro schemi di luce nel tentativo di replicare determinate tipologie di illuminazione naturale attraverso una illuminazione artificiale, costruita in studio.
Questo si ricollega a un mio modo di raccontare delle storie attraverso la fotografia utilizzando i tre registri lacaniani: l’onirico, il simbolico, il realista. Fondamentalmente io racconto delle situazioni reali attraverso delle trasposizioni di tipo onirico, e cosa c’è di più simbolico dell’onirico?
“Questo accade ad esempio con degli artifici tecnici, attraverso l’utilizzo di ottiche particolari, con dei grandangoli che non replicano la visione umana ma danno delle prospettive esasperate che mi servono per raccontare delle realtà per come le vedo io, per come le sogno io e per quello che rappresentano per me.”
La fotografia come un campo di forze personali, emotive e sensibili. Un medium linguistico attraverso cui dare forma alle favole, ai sogni, alla musica perfino, come se le immagini potessero diventare degli spartiti visuali. Un modo per affermare la propria istanza umana e artistica, per raccontare frammenti del mondo, di un noto dai contorni di ignoto. In quel continuum che è la vita e che non ha bisogno di definizioni.
Desidero ringraziare per la cortese intervista Matteo Guariso – web site – Facebook – Instagram. I suoi lavori sono rappresentati da Noema Gallery (Milano)
In copertina: Matteo Guariso, Luce #5
Matteo Guriso, Luce #1
Matteo Guariso, Luce #1
Matteo Guariso, ritratto di Claudio Magris & Geert Van Istendael
Matteo Guariso, ritratto di Claudio Magris
Matteo Guariso, Oblivion
Matteo Guariso, Teatro Bibbiena (Mantova)
Matteo Guariso, Self portrait