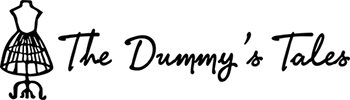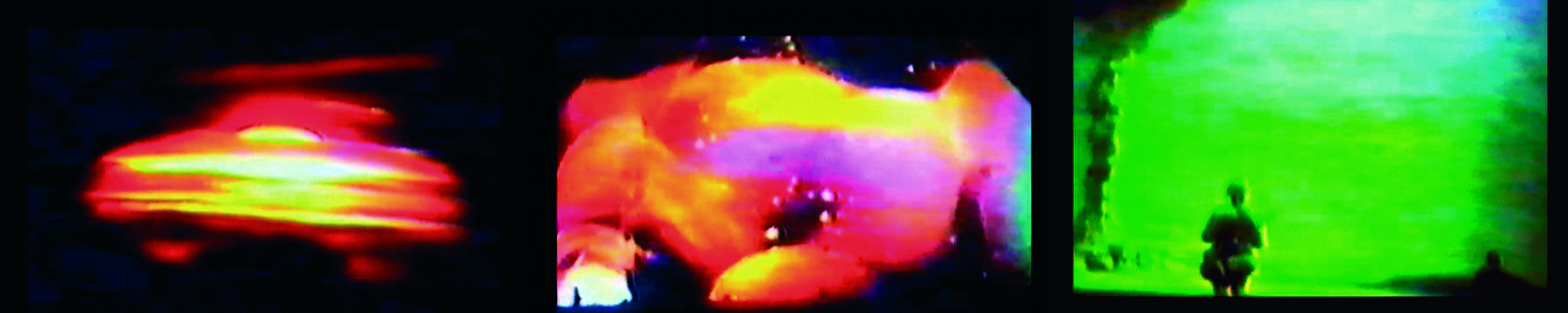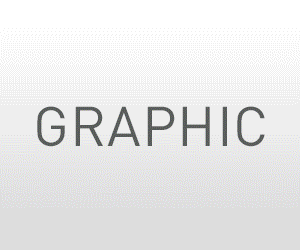Stefano Cagol (Trento, 1969) è un artista contemporaneo la cui pratica multiforme si avvale di differenti media: il video, la fotografia, le installazioni e la performance art. I temi che compongono il nodo teorico della sua poetica spaziano dalle questioni ambientali a quelle climatiche, dall’interferenza dell’uomo nei processi della natura alle frontiere che separano gli Stati tra loro.
Formatosi a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera e successivamente alla Ryerson University di Toronto, dove ha ottenuto una borsa di studio post-dottorato del governo canadese, Cagol è stato artista in residenza in numerose città del mondo: New York, Londra, Salisburgo, Gartenau in Austria, Kirkenes in Norvegia. Vincitore, nel 2019, della sesta edizione del premio Italian Council, promosso e sostenuto dal MIC (Ministero della Cultura), sta attualmente lavorando a un progetto internazionale dal titolo The Time of the Flood. Beyond the myth through climate change che si svolge tra Berlino, Tel Aviv, Roma, Venezia e Vienna. Da ultimo ha rappresentato, con la performance The Diviner (The Time of the Flood), la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona alla 17^ Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani).
Le sue opere dal carattere installativo, performativo, tecnologico e partecipato – che danno vita a quello che il linguaggio della critica artistica definisce un sistema “complesso” (Alessandra Piatti, Ricerche di S/Confine, vol. VI, n. 1 (2015)) – mantengono una forte relazione con lo spazio espositivo, un imprescindibile rapporto con il fruitore, che è più o meno attivamente chiamato a interagire con esse, e la variabile della componente temporale.
© Stefano Cagol, Flu Power Flu, 2007, installation, neon tubes, 3 blinking phases of 5 seconds each, Plexiglas, aluminum structure, 1.5 x 12.5 m. Beursschouwburg kunstencentrum, Bruxelles
Francesca Interlenghi: Fin dagli esordi, a partire dal video Monito. Monition. Mort Nucleaire. (1995) in cui il suono di un’esplosione atomica si accompagna alle immagini distorte della documentazione di test nucleari, la tua ricerca si è concentrata su temi molto specifici: le sorgenti energetiche, il cambiamento climatico, il rapporto uomo/natura, i confini tra gli stati, e le implicazioni politiche che ne derivano, e il fenomeno della globalizzazione. Cosa pensi abbia contribuito a definire in maniera così radicale la tua indagine?
Stefano Cagol: Tutto il mio lavoro muove dall’idea che l’arte debba dire delle cose, che l’artista debba farsi promotore di un ruolo attivo, che debba impegnarsi in maniera autentica e non solo per finalità estetiche. Mi considero un attivista, sebbene non mi piaccia l’attivismo oltranzista. A me interessa invece esplorare le potenzialità dell’arte, la sua capacità di esprimere delle idee, dei concetti, lavorando sul connubio tra forma e contenuto. L’estetica non va trascurata, anzi per me è molto importante. Ma fin dagli inizi tutti i miei lavori, anche quelli di un certo periodo che parevano focalizzarsi più sui paesaggi metropolitani, hanno avuto forti connotazioni politiche, sociologiche, antropologiche, ecologiche. Oggi, i temi che sono sempre stati oggetto della mia indagine artistica, sono diventati prioritari nelle agende dei leader mondiali. Ma quando nel 2007 a Bruxelles ho realizzato l’opera Flu Power Flu, in tubo al neon, plexiglas e alluminio, ispirata dall’aviaria tra influenze, potere e pandemie, esposta successivamente al museo MA*GA di Gallarate durante la mia personale del 2019, mi hanno additato anche come folle. Profeta? Divinatore? Anticipatore dei tempi? Non lo so. So che come artista, e come attivista, sono ovviamente piuttosto sensibile a quanto avviene e sta per avvenire. Ho una gran fame e ho sempre dovuto combattere molto. Forse, tutte queste cose insieme hanno determinato la mia ricerca.
© Stefano Cagol, Monito. Monition. Mort Nucléaire, 1995, VHS video, transferred to DVD, 14 min/loop
Francesca: Torno sul tema della globalizzazione perché legato alla questione dei confini geografici, e del loro mutare, che sono oggetto del tuo interesse artistico e delle tue sperimentazioni con la luce. L’opera Light Dissolution (of the borders). Dissoluzione di Luce. Aufloesung im Licht. (2008) consisteva in un potente faro posto al confine tra Trentino e Sud Tirolo. Una linea di divisione inesistente nella carta geografica ma che separa effettivamente due culture, quella di lingua tedesca e quella di lingua italiana. Immagino che ciò abbia a che fare con il vasto tema dell’identità e con la sua fluidità. E anche con l’attribuzione di nuovo senso ai concetti di centro e periferia, come conseguenza appunto della globalizzazione.
Stefano: Certamente le mie origini hanno un ruolo importante in queste opere realizzate con i fasci di luce. Vengo dal Trentino Sud Tirolo dove il tema del confine è molto sentito. Inoltre, avendo abitato in Svizzera, da bambino negli anni Settanta, dato che mio padre lavorava al consolato, ho avuto modo di sperimentare sulla mia pelle cosa si prova ad essere italiani all’estero. Confine significa tante cose: vuol dire identità, sofferenza, differenze, ma anche possibilità di costruire nuove relazioni e nuove visoni. Come quando sono stato al confine tra Russia e Norvegia e al centro della diga che attraversa il fiume Pasvik älv: nella cosiddetta terra di nessuno dove allungando la mano si può oltrepassare il confine tra i due Stati, ho posizionato il mio faro osservando la linea di demarcazione tra i due Paesi muoversi sinuosa per quindici chilometri. Proprio lavorando in Norvegia, in mezzo al nulla, ho iniziato a capire quanto ininfluente sia, in ultima analisi, stare in un luogo piuttosto che in un altro. New York, Londra, Parigi o in cima a una montagna, non fa molta differenza. Siamo noi stessi il centro e se esprimi cose importanti puoi stare ovunque.
© Stefano Cagol, The End of the Border (of the mind), 2013, action, beacon, 7000 W, power generator, van, labels
Francesca: Parli di luoghi lontani e questo mi offre lo spunto per approfondire un altro tema, quello del viaggio: elemento centrale della tua poetica, direi medium esso stesso. Scriveva bene Castiglioni, curatore della tua mostra e conservatore senior del Museo MA*GA, che le tue opere non si concludono con la realizzazione di un oggetto visivo ma potenzialmente continuano, si riconfigurano costantemente muovendosi nello spazio e nel tempo. A questo contesto mi pare ascrivibile anche il carattere performativo di tutto il tuo lavoro.
Stefano: L’opera per me non è statica, ma si muove. La mia modalità di coinvolgere diverse istituzioni in giro per il mondo è anche un modo, a ben vedere, di concepire l’opera come qualcosa che non ha solo valenza site specific, ma anche time specific. A questo si aggiunge il fatto che sempre più la performance, l’utilizzo del corpo e la relazione con lo spettatore, assumono un ruolo centrale nel mio lavoro. Da un lato c’è certamente un ego spiccato, un Io che vuole espandersi e dire con ogni mezzo, che vuole parlare al mondo intero. Dall’altro c’è anche un approccio multidisciplinare all’intero processo di costruzione dell’opera. Questa idea dell’artista capace di confrontarsi con strumenti diversi, e differenti linguaggi, è molto importante per me. Fin dagli esordi ho fatto sempre tutto da solo, senza avvalermi dell’aiuto di nessuno. Così per i video: mai nessuna troupe, anche a costo di un risultato magari tecnicamente imperfetto. Ma realizzare i video è già un’azione di per sé. Andare nell’Artico, in completa solitudine, a fare le riprese, era già una sorta di performance. E anche guidare in solitaria un van da Trento a Berlino, come ho fatto per il progetto Bird Flu Vogelgrippe (2006). Una riflessione sull’influenza che il potere dei media, e il bombardamento di informazioni a cui siamo costantemente sottoposti, hanno sulla nostra vita quotidiana, un progetto itinerante che era al contempo un’installazione e un’azione che coinvolgeva il pubblico. Quest’ultimo veniva attirato da un canto di uccelli che fuoriusciva da un furgone bianco, con la scritta Influenza Aviaria su un lato, parcheggiato difronte a luoghi artisticamente significativi e monumenti storici che evocano anch’essi influenza e potere. La performance fa sicuramente parte di questo mio approccio pluridisciplinare all’arte.
© Stefano Cagol, Bird Flu Vogelgrippe, 2006, 35 mm photograph, lambda print, diasec, 105 x 160 cm
Francesca: Si parla molto di Capitalocene ultimamente, teoria secondo la quale il cambiamento climatico non è il risultato dell’azione umana in astratto – Anthropos – bensì la conseguenza più evidente di secoli di dominio del capitale. Alla tensione, meglio dire contrapposizione, del rapporto uomo/natura sembra fare eco, nella tua pratica, la natura contrapposta dei materiali che utilizzi. Fuoco e acqua sono protagonisti indiscussi di molte tue opere. Mi puoi parlare del ghiaccio e in particolare dell’opera The Ice Monolith (2013)?
Stefano: Ho realizzato quel lavoro in occasione della 55^ Biennale di Venezia. Si trattava dell’installazione di un enorme blocco di ghiaccio, di dimensioni 200 x 120 x 50 cm., parte del Padiglione delle Maldive, posizionato in Riva Cà di Dio. Destinato a sciogliersi per via della temperatura estiva, il monolite è durato 72 ore e ha finito per confondersi con l’acqua della laguna, sollevando una serie di riflessioni sugli effetti che i cambiamenti climatici producono sul nostro pianeta, in particolare la sparizione dei ghiacciai, di quello che abbiamo sempre considerato il ghiaccio eterno. Nel suo saggio Terra Incognita: Exhibiting Ice in the Anthropocene, Julie Reiss, direttore del Masters program in Modern and Contemporary Art di Christie’s New York, mette a confronto l’installazione di ghiaccio di Olafur Eliasson, intitolata Your waste of time, con la mia. Entrambe esposte nello stesso periodo, sebbene in contesti diversi e opposte, in un certo senso, tra loro. Quella di Eliasson consisteva infatti in grandi pezzi di ghiaccio di forma irregolare staccati dal più grande ghiacciaio islandese, il Vatnajökull, in mostra in una collettiva al MoMA/P.S.1 in una stanza appositamente refrigerata per conservarli. Già nel 2006 aveva movimentato pezzi di ghiacciaio per portarli in una galleria di Berlino, ma raccontato in un’intervista che al momento non voleva parlare di cambiamenti climatici bensì innescare un’esperienza viscerale. Io, dal canto mio, cercavo di accorciare la distanza sociale generata dalla disuguaglianza, che maschera la comprensione collettiva e la consapevolezza dell’immanenza degli impatti climatici. In un modo o nell’altro, per me la cosa importante è che questi argomenti abbiamo rilevanza e risonanza globale.
© Stefano Cagol, The Ice Monolith, 2013, ice block, 200 x 120 x 50 cm. Riva Ca’ di Dio, Maldives National Pavilion, 55th Venice Art Biennale
Francesca: Per concludere, tu parli di diluvio come della summa di tutte le catastrofi. Non è semplicemente una massa d’acqua, ma lo sconvolgimento dell’ordine delle cose. Attingi dal mito dove le manifestazioni più violente tendevano ad essere guidate dagli dei, che gestivano la nostra esistenza. Pensi che l’Uomo possa sopravvivere al diluvio? In altri termini, può l’essere umano sopravvivere a sé stesso?
Stefano: Il mito del diluvio è millenario ed è presente in tutte le culture, perché in fondo noi abbiamo questo senso di autodistruzione, da sempre. Ma diluvio significa anche rinascita, significa che qualcuno si salva e, auspicabilmente, si riparte. Probabilmente l’Uomo non sparirà mai del tutto, ma l’idea che possa sparire la nostra civiltà è plausibile. Perché è così, perché siamo fatti male, perché siamo aggressivi. C’è questa ambivalenza nel genere umano: siamo da sempre poeti, artisti, esseri meravigliosi insomma, ma allo stesso tempo assassini e prevaricatori. In molte mie performance io stesso esterno questo aspetto violento, perché noi siamo fatti così, perché questa dicotomica alternanza è genetica ed è inutile far finta che non esista. Ma distruggendo l’equilibrio della natura, l’Uomo distrugge tutto. Il suo desiderio di onnipotenza, il suo atteggiamento predatorio, decreterà la sua fine. A meno che non ci convinciamo che dobbiamo instaurare un rapporto simbiotico con la natura. E’ la simbiosi che vado predicando. Forse, l’unica via per la salvezza.
© Stefano Cagol, mist (the time of the flood), 2020, opera fotografica
Cover story: © Stefano Cagol, The Diviner (the time of the flood), 2021, HD video, 8 min/loop
Stefano Cagol, web site – Facebook – Instagram