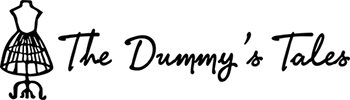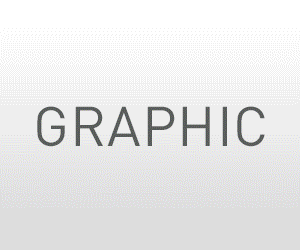Prendere posizione rispetto alla vita inquadrando, decidendo cosa fotografare e come fotografare. E usare la fotografia come una grammatica con cui scrivere, con cui tracciare le vicende umane. Dire della luce smagrita, impigliata nei visi della gente. Di giorni di un colore grigio, appesi a un cielo di aria tumefatta. Di muraglie diroccate, come resti di una immane battaglia. Di aquiloni, senza più filo né vento.
“Ho iniziato questo lavoro alla fine degli anni ’70 con la documentazione delle guerre civili in centro America: Nicaragua, Salvador, Guatemala, perché allora i fatti politici succedevano lì. Fino a quel momento avevo praticato sport agonistico, ero nella nazionale di scherma, e perciò avevo avuto la possibilità di viaggiare soprattutto in Paesi che all’epoca non era facile raggiungere, quelli dell’oltrecortina. Le nazionali più forti erano infatti l’Ungheria, la Russia, quelle dell’Est. Non sono quindi partito da una vera e propria passione per la fotografia, direi che sono partito dalla passione per il racconto umano. Guardavo quello che succedeva nel mondo e volevo raccontarlo con i miei occhi senza aspettare che qualcuno lo facesse attraverso i giornali o la televisione. Era in pieno svolgimento la guerra del Vietnam e le immagini che vedevo su Epoca, l’Europeo o Life restavano impresse come fossero sintesi di così tante cose che a volerle scrivere bisognava riempire colonne intere di parole.”
I teatri di guerra più cruenti del mondo: gli slums di Nairobi, lo Sri Lanka, la Somalia, la Sierra Leone. La tragedia delle ragazze sfigurate con l’acido in Bangladesh e le prostitute bambine. La vicenda di Padre Alex Zanotelli quando lavorava in una discarica di Nairobi. Storie raccontate ai tempi in cui la carta stampata produceva contenuti di valore e non si limitava a essere contenitore di pubblicità e di umanità varia, in prevalenza senza spessore, che solo sa nascere e morire al ritmo breve della propria inconsistenza. Storie narrate prima che il mondo cambiasse, in peggio. E prima che la stessa fotografia cambiasse, per le nuove generazioni.
“Perché una volta il reportage non era solo prendere e partire ma era saper tutto del luogo di destinazione. La cronaca certo, ma anche la letteratura, la politica, l’economia, tutti elementi che diventavano tessere nella memoria e che trovavano nelle foto la loro collocazione naturale, come fossero pezzi di un puzzle e ogni tassello un contenuto. Quando la fotografia era analogica si scattava di meno e si pensava di più. Intanto, banalmente, per una questione di denaro perché i rullini costavano e poi perché era necessario capire a priori quello che si doveva fare, nell’attesa che l’immagine si componesse. Oggi invece si scatta e si guarda senza costruire l’immagine, si scatta e si guarda senza avere nemmeno il tempo di capire e metabolizzare quello che si vuole fare. La fotografia è molto cambiata ed è molto cambiata la percezione dei giornali nei confronti del fotogiornalismo. Le organizzazioni non governative o le Onlus, con le quali già collaboravo perché nelle zone di conflitto erano loro a offrire un letto e del cibo in cambio solo di una foto, hanno sostituito degnamente, anzi a volte in modo anche migliore, i giornali. Virare dalla realtà dell’editoria a realtà come SoleTerre o Pangea mi ha permesso di continuare a fare il mio lavoro nell’unico modo in cui so farlo: in maniera approfondita e seria.”
Un sentimento del mondo dentro il quale tutte le immagini si svelano, in fondo agli occhi, come la sera quando le ombre si addensano contro i muri. E un limite, un confine che è il tuo, che nessuno ti insegna e che è indipendente dal mestiere che fai.
La sensibilità è in noi, che tu faccia il fotografo o altro non cambia. La capacità di capire quando fare un passo avanti o uno indietro difronte al dolore altrui non te la può insegnare nessuno.
“Mi ricordo che una volta, in uno dei primi momenti di questo lavoro, ero in un villaggio di nome Rosita, al confine con l’Honduras, e in una baracca c’era un morto ancora scoperto che i figli e la moglie stavano piangendo. Io sono arrivato e mi sono fatto da parte. Ma dopo poco uno dei figli mi si è avvicinato chiedendomi di entrare perché in quel momento io ero l’unico tramite tra quello che stava succedendo e quello che potevo far conoscere al mondo. Se in qualsiasi parte del mondo una cosa succede e nessuno la fa sapere allora quella cosa è come non fosse mai successa. Ho capito in quel momento che non documentare equivaleva a non essere di aiuto a nessuno.”
Il senso di chi fa il mi lavoro è quello di portare alla luce avvenimenti, fatti e situazioni che altrimenti non avrebbero voce.
E così l’esperienza, non la puoi imparare in nessun libro, la fai solo sul campo, in presa diretta. “Ho avuto paura e momenti di tensione ce ne sono stati ma mi ritengo fortunato perché quando ho commesso grandi sbagli quegli sbagli potevano essere perdonati. Se li commettessi oggi probabilmente no.” Momenti gusti per capire che non valeva la pena fotografare, che quello scatto non avrebbe fatto la storia della fotografia, una invadenza inutile, un fatto interno, personale e intimo, che imponeva di posare la macchina. Momenti giusti per essere prudenti, per non innescare situazioni di aggressività dall’esito incerto. Momenti giusti per lasciar andare il lavoro di giorni e giorni, quello che ti portavi sempre dietro e poi in un attimo veniva sequestrato, in Palestina e nei territori occupati, e allora di nuovo a ricominciare tutto da capo.
Se dovessi sintetizzare tutto quello che questo lavoro mi ha fatto capire è che la vita è sottrazione e non addizione.
“La nostra è una società in cui ti abituano fin da quando nasci ad aggiungere, perché più possiedi e più sei visibile, e anche condivisibile, e più hai successo. Ma nella grande parte di mondo che ho girato ho visto come le persone vivono con poco e ho capito che le cose importanti nella vita sono 2 o 3, non 300, e anzi quelle 297 in più ti fanno perdere di vista ciò che è essenziale. Per raccontarlo ho scelto la fotografia ed è diventata il mio linguaggio narrativo. Dentro ci metto la mia visione del mondo, la mia cultura, i miei pregiudizi anche, e quello che al momento dello scatto mi sembra essere la realtà da fotografare. Ci metto l’uomo e il fotografo, che non sono due figure diverse. E’ la stessa figura, che mi porto appresso. Finché le forze me lo consentiranno.”
Il dono non è stare alle cose
intraviste con gli sguardi del sogno;
la veglia è il dono, il nudo rimanere
in ciò che vedi,
nei passi ad occhi aperti,
alla mite condanna di ogni giorno.
(Sergio Zavoli, L’orlo delle cose)
Desidero ringraziare Ugo Panella per il tempo dedicato a questa nostra conversazione. www.ugopanella.it – Facebook