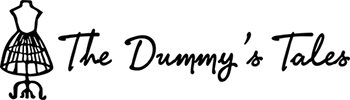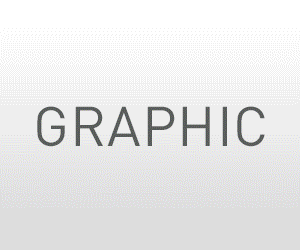Disadorno. Sdrucito. Fragile. Malinconico. Sono solo alcuni dei termini intorno ai quali sto provando a costruire una riflessione di senso compiuto sul tema della possibilità di produrre singolarità in un mondo sempre più standardizzato. Provando a portare all’interno dei confini della moda un linguaggio anch’esso disadorno, nel senso di ridotto all’essenza, che rispecchi una concezione di bellezza imperfetta e fragile, aderente al carattere transitorio di tutte le cose, noi per primi.
Un linguaggio sempre proteso in avanti, verso un ideale di perfezione, che armonizzi in qualche modo il caduco e il duraturo, il fugace e il costante, il mutevole e il saldo. Un linguaggio che traduca le istanze di una piccola eppure decisiva ed energica nicchia di pensiero votata a sovvertire codici vestimentari dominanti.
Wabi-sabi è per i giapponesi l’arte di trovare bellezza nell’imperfezione, è cogliere il valore della deperibilità, il gusto malinconico dell’inevitabile appassire delle cose. E’ tensione verso la perfezione che passa attraverso il culto dell’imperfezione.
Nei volumi degli abiti, nelle diverse gradazioni del nero, negli orli imprecisi, nelle asimmetrie, nel tagliuzzamento della materia, ridotta quasi a brandelli, nella commistione di maschile e femminile, Yohji Yamamoto rivela tutti i segni visibili di una frammentarietà che ci riguarda tutti, in quanto esseri umani intendo.
E rivela al contempo la natura inafferrabile della donna, hito in giapponese. A significare la vastità del suo animo custodito in abiti che sono dei veri e propri contenitori per il corpo e prendono il loro spazio e sul corpo si adagiano.
Un lavoro strettamente connesso alla sessualità che mette in campo una femminilità diversa: una donna che si copre, che copre l’esteriorità per far emergere una sensualità più forte, profonda e innata. Espressioni fugaci, piccole porzioni di corpo concesse allo sguardo, niente altro. Il resto è seduzione intellettuale. Desiderio di invisibile. Tensione verso l’infinito.
“Ever since I can remember, a woman has always existed within me, like a faint shadow. She is not young. She is not Japanese. She is always looking away from me. I am always pursuing her. But I never reach her. If she spoke, her voice would be raspy. She is a woman who has given up being a woman…” (Yohji Yamamoto, My Dear Bomb)
Tratto dai miei Appunti per un Manifesto per una Alter-Modernità
Io indosso un abito di Yohji Yamamoto (dal mio archivio)
Foto di Elisabetta Brian
Location Galleria Raffaella Cortese
Alla parete un’opera dell’artista Mathilde Rosier (dalla mostra “Impersonal Empire, The Buds” che ha avuto luogo in galleria nel maggio 2018)